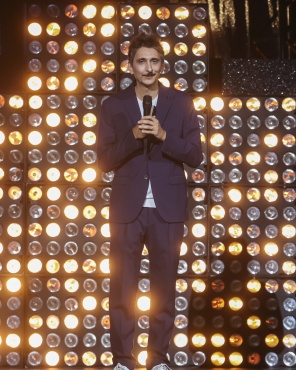È impossibile confinarla in un solo genere o in un’unica epoca. Passando dall’eleganza sofisticata dei Matia Bazar alle sperimentazioni audaci della sua carriera da solista, Antonella Ruggiero ha attraversato oltre quarant’anni di musica italiana mantenendo intatta la sua identità artistica: intensa, visionaria e in continua evoluzione. La sua voce, unica nel panorama nazionale, non è mai stata solo uno strumento tecnico, ma un vero e proprio specchio della sua interiorità. È diventata negli anni veicolo di ricerca continua: non solo musicale, ma anche spirituale, poetica ed esistenziale. Dall’elettronica al sacro, dal pop all’etnico, ha saputo intrecciare suoni, culture e linguaggi in una forma espressiva che sfugge alle classificazioni, conservando sempre una coerenza profonda, nutrita da silenzi e ascolti. Nel suo percorso, ogni progetto ha rappresentato una tappa di trasformazione, un’occasione per spingersi oltre i limiti imposti dall’abitudine o dal mercato. In occasione della sua partecipazione a Musicultura, prima della sua esibizione sul palco dello Sferisterio per la seconda serata finale del Festival, ha condiviso con la nostra redazione il racconto del cammino che l’ha portata fin qui: un itinerario fatto di libertà, profondità e fedeltà a se stessa. È tra le righe, nei gesti misurati e nelle parole scelte con cura, che affiora l’idea della musica non come traguardo, ma come un viaggio in continua evoluzione, che si rinnova ogni volta che si ha il coraggio di ascoltarsi davvero e di offrirsi al mondo senza maschere.
A Musicultura, tanti giovani cantautori cercano la loro voce. Cosa direbbe oggi alla “Matia” del suo primo 45 giri, se potesse parlarle?
Probabilmente le direi di esprimersi con libertà, facendo ciò che sa fare nel modo più autentico possibile, senza lasciarsi bloccare dai troppi pensieri. È normale, all’inizio, sentirsi sopraffatti dalla tensione. Ma proprio per questo le suggerirei di ascoltarsi, di seguire ciò che sente davvero dentro: è lì che si trova sempre la direzione giusta.
Ha collaborato con musicisti, artisti visivi, cori. Esiste un’arte o una disciplina con cui sognerebbe ancora di intrecciare la sua voce?
No, direi di no. Perché, pur senza voler esagerare, credo di averle esplorate quasi tutte, anzi, forse proprio tutte. L’ultimo progetto, Altrevie, è stato un vero e proprio azzardo, spinto fino in fondo. Ed è proprio questo ad averlo reso così divertente, surreale, suggestivo. Quindi no, al momento non credo ci sia un’arte con cui sogno ancora di intrecciare la mia voce, ma le idee, si sa, arrivano all’improvviso e ci si ritrova a inseguirle.
Ecco, ha appena citato il suo ultimo progetto discografico, Altrevie. In quest’album ha sperimentato molto anche con la manipolazione digitale della voce. Nel corso del tempo quanto è cambiato il suo modo di “usarla” come strumento?
La voce è sempre stata il mio strumento e con il tempo l’ho affinata. Così come cambiano il modo di vedere la vita, di pensare e di sentire, anche la voce si trasforma: segue i pensieri, le emozioni, le dinamiche interiori. Non a caso, la mia voce di un tempo è profondamente diversa da quella di oggi. Ma non è solo una questione anagrafica: è l’intenzione che cambia. Sono le esperienze vissute, stratificate nel tempo, a dare profondità e spessore alla voce, insieme, naturalmente, all’interpretazione di ciò che si canta.
La spiritualità è una componente che ritorna spesso nella sua musica. Come si traduce oggi, nel suo quotidiano, questo legame tra suono e dimensione spirituale?
In realtà non ci penso. Vivo senza soffermarmi su certi temi. Per quanto mi riguarda, la spiritualità è qualcosa di profondamente legato alla natura. Quando mi trovo immersa in essa, il pensiero va spontaneamente oltre. Non c’è nulla di costruito, nulla di artefatto che mi conduca lì: è un processo del tutto naturale. È semplicemente nella mia indole, così come lo è per milioni di altre persone, fare scelte e maturare pensieri in una certa direzione.
Quale ruolo ritiene possa avere un festival come Musicultura nel favorire non solo lo sviluppo della carriera, ma anche la crescita artistica, introspettiva e musicale dei suoi vincitori?
Credo che, prima ancora di pensare alla carriera, sia fondamentale costruirla con il tempo e attraverso le esperienze, altrimenti rischia di restare qualcosa di indefinito, che non prende mai forma concreta. Essere qui, per i vincitori, è importante proprio perché non si trattano brani superficiali o senza radici; qui la ricerca è, prima di tutto, umana, ed è da lì che nasce quella artistica. C’è l’individuo, ci sono il ragazzo o la ragazza con un mondo interiore da esprimere, qualcosa da dire e da dare, prima di tutto a se stessi e poi agli altri. L’arte richiede pazienza, ascolto e tanta introspezione. E più si riesce a stare lontani dalle dinamiche del successo facile, più si ha la possibilità di coltivare qualcosa di autentico e duraturo.